La luce che risplende nel buio
Mostra di un pluriomicida
“ Macinava li colori in Milano, et apprese a
colorire, et per haver occiso un suo compagno fuggì dal paese “ - La vita dei pittori - G. Baglione, 1642
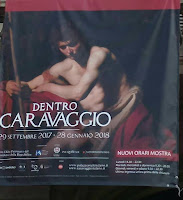 Si
è aperta a Milano in ordine cronologico la terza mostra su uno degli innovatori (insieme a
Rubens) del Barocco e della pittura moderna “ Dentro Caravaggio “.
Si
è aperta a Milano in ordine cronologico la terza mostra su uno degli innovatori (insieme a
Rubens) del Barocco e della pittura moderna “ Dentro Caravaggio “.
La
prima mostra a lui dedicata fu nel dopoguerra, grazie allo storico d’arte e
collezionista Roberto Longhi che studiò e riabilitò Caravaggio principalmente come
l’inventore del chiaro/scuro ma non solo, la seconda “Caravaggio e i
caravaggeschi“ dedicata anche alla corrente di pittori seguaci che hanno
operato nell’Italia Meridionale, e ora questa che porta il visitatore alla
scoperta di una mostra scientifica
caratterizzata da pannelli multimediali che descrivono il quadro tramite l’uso
della radiografia e mettono in luce i colori tramite la riflettografia
rilevando dettagli altrimenti non visibili ad occhio nudo.
E’
la mostra di un pluriomicida, i cui frequenti spostamenti avvennero a causa di
risse e denuncie da parte di compagni ma anche di personaggi illustri.
Nato
a Milano il 29/09/1571, da genitori provenienti da Caravaggio, -il padre
artista forse maestro scalpellino lavorava al Duomo-, abitava in Via Laghetto
dove anticamente in Milano sul Naviglio navigavano le chiatte che dal Ticino e
dal lago Maggiore trasportavano il marmo per il Duomo di Milano. Fu battezzato
nella Chiesa di S. Stefano in Brolo il 30/09 nel giorno di San Michele Arcangelo
e gli fu dato nome di Michelangelo.
Qualche
anno dopo aver fatto ritorno a Caravaggio a causa di una epidemia di peste la
famiglia Merisi si stanziò di nuovo a Milano dove Michelangelo fu assoldato da
Simone Peterzano, allievo di Tiziano, i cui affreschi abbelliscono la bella
Chiesa di San Maurizio detta la Cappella Sistina di Milano, e la Certosa di Garegnano.
Durante il soggiorno a Roma dopo aver conosciuto il monsignor Pandolfo Pucci da
Recanati detto monsignor “insalata” perché pare gli fornisse dell’insalata come
unico alimento, fece il salto di qualità con il cardinale Francesco Maria del
Monte che abitava a Palazzo Madama e gli commissionò i primi lavori nella
Chiesa di S. Luigi dei Francesi per
decorare la Cappella Contarelli in occasione del Giubileo del 1600, i cui
dipinti raccontano la Conversione di Matteo e, per la Cappella Cerasi nella
Basilica di Santa Maria del Popolo, la Caduta di S. Paolo dal cavallo e la
Crocefissione di San Pietro.
Riscosse così successo tra gli ambienti romani e
dipinse anche per famiglie che gli commissionarono dipinti per la devozione
personale. Un quadro di questo tipo è La Sacra Famiglia con S. Giovannino di
una collezione privata un dipinto che incanta in cui la Madonna cattura lo sguardo
del visitatore e lo porta dentro il quadro fatto di giochi di sguardi e gesti
invitandolo quasi a partecipare alla scena.
Nei
suoi quadri Caravaggio esprime una drammaticità teatrale, le scene sono
studiate e composte, è sempre molto attento alle figure umane, ai contrasti
chiaro scuri e ai simbolismi che racconta nella vegetazione, mentre il
paesaggio è più raro. Infatti con la
Canestra di Frutta, dal significato allegorico sulla vita e sulla morte
rappresentato dalla frutta buona e da quella marcia, nasce la natura morta come
elemento parziale di un paesaggio che fino ad allora in ambito lombardo era una
tradizione antica dipingere con l’immancabile lago. Il celebre quadro fu commissionato dal Cardinale Federico Borromeo
parente della marchesa di Caravaggio Costanza Colonna, famiglia che lo protesse
sempre durante i suoi spostamenti.
Anche
il Riposo durante la fuga in Egitto ci svela molti elementi simbolici
naturali nel paesaggio e nei personaggi, l’Angelo Musicista con la
veste trasparente, Giuseppe che gli regge lo spartito la cui partitura riporta
le note del mottetto Quam Pulchra es basato sul Cantico dei Cantici, mentre la
Madonna col capo piegato che abbraccia il Bambino, è raffigurata con i capelli
rossi e ha il volto di una delle cortigiane amiche di Caravaggio.
Nei
dipinti Caravaggio ritrae nel volto delle sue Madonne due prostitute di Campi
dei Fiori, Anna Bianchini e Fillide Melandroni come nella Conversione della
Maddalena, nel bellissimo Madonna dei Pellegrini, dove sull’uscio della casa
della Madonna di Loreto è una prostituta con in braccio il figlio che i
pellegrini devoti dai piedi scalzi e
sporchi giungono per adorare, e nella Giuditta e Oloferne in cui Giuditta è Anna Bianchini, mentre in
Giuditta e Marta, Anna è con Fillide
Melandroni a causa della quale verrà poi
condannato a morte per omicidio dopo una lite nel 1606.
E’sorprendente
scoprire poi nella Buona Ventura come tramite la radiografia che mette in luce il tondo eseguito con il compasso del cappello
del giovinetto , al quale la zingara sta sfilando l’anello nell’atto di leggere
la mano, in una precedente stesura fosse l’aureola di una Madonna pronta per
l’incoronazione.
Ma è con il Ragazzo morso dal Ramarro, che il
fondo comincia a essere scuro. La tela reca numerose microincisioni che
impostano la composizione dipinta con una tecnica innovativa sia per il modo
con cui appoggia la mano su un lato della tela per farsi l’autoritratto che
nella preparazione dei colori per il fondo e per i tocchi di luce.
Caravaggio
introduce il mondo del notturno.
Ogni
quadro è un tripudio di ombre e luci che avvolgono sinuose le figure dei dipinti
; ecco nella carrellata dedicata ai Santi il San Francesco in estasi il Santo
più rappresentato insieme a San Giovanni Battista, il cui volto è il ritratto
del Cardinale Del Monte dove i fili d’erba, le foglie, la margherita sono il
simbolo della rinascita dopo le stigmate, i santi San Giovanni Battista e San
Gerolamo penitente realizzati per stimolare la conversione del popolo durante
la minaccia della Riforma Luterana con ben rappresentato lo strappo del
drappeggio del tessuto della veste, o la rappresentazione dei corpi sporchi e
seminudi ricoperti poi nel 1700 da pannelli di altre mani nell’ Incoronazione
di spine di Cristo, o nella Flagellazione, quadro del soggiorno napoletano facente
parte della pala d’altare della Chiesa di San Domenico Maggiore in cui
risaltano i particolari tridimensionali, e ancora il San Francesco in Preghiera
o il drammatico Sacrificio di Isacco dove
ritroviamo il paesaggio dell’Italia Centrale con annessa rupe e castello, in
cui in realtà Caravaggio vuole rappresentare una scena bucolica con l’angelo
che ferma la mano di Abramo dipinto con aria serena tanto che la mano e il coltello
che erano vicini al collo del ragazzo nel disegno sono stati allontanati.
Infine
chiudono la rassegna in mostra il Cavaliere dell’Ordine di Malta, in cui
Caravaggio durante il soggiorno a Malta ritrasse il suo protettore nella veste
del Gran Maestro, e dopo aver avuto accesso al grado più basso dell’Ordine
forse per ottenere favoritismi e sconti sulla pena di morte fu costretto a
fuggire anche dall’isola in seguito ad una lite, per approdare in Sicilia a
Siracusa, dove pare coniò il termine Orecchio di Dioniso alla Grotta delle Latomie.
Dopo brevi soggiorni nuovamente a Napoli,
partì per il Feudo degli Orsini in
attesa della conferma della revoca della sua condanna da parte del Papa Paolo
V, trasportando anche le tele che servivano per riscattare la sua libertà ma a
causa di disguidi con la sorveglianza della costa e ammalato di febbri
intestinali morì a Porto Ercole nel 1610
a 39 anni.
L’ultimo
quadro che chiude la mostra è il Martirio di S. Orsola dipinto per la famiglia
Doria di Genova che sembra non finito, ma in realtà essendo stato spedito
avvolto nella protezione ancora non asciutto, al momento del ricevimento venne
messo al sole per farlo asciugare, aggiungendo danno al danno.
Caravaggio
fu sepolto nella fossa comune sulla spiaggia che oggi è parte del porto. Più
tardi uno studioso di storia di Napoli spostò la morte sulle rive di Palo di
Ladispoli nel Lazio dove pare fosse stato assassinato da emissari dei Cavalieri
di Malta con il bene tacito della Curia di Roma. Ma nel 2010 altri scienziati
italiani ritrovarono ossa, contenenti piombo e mercurio usati nella
preparazione dei colori, nella fossa comune del cimitero di Porto Ercole e
grazie agli esami del DNA e della datazione del carbonio 14 pare essersi
risolta la diatriba sulla sepoltura di un artista tanto “ fetido e putrido”
quanto Genio della storia dell’Arte .
S.C.
Info:
Dentro Caravaggio, Palazzo Reale di Milano
Fino al 28 gennaio 2018


Commenti
Posta un commento